Il giardiniere bene della collettività: la storia del capo squadra ai Giardini Reali di San Marco
Eduard Bodi è il responsabile ai Giardini Reali di San Marco e all’Orto del Redentore. Dal The Holme di Londra all’isola degli Armeni a Venezia: il mantra è terra e artigianato

Le mani sporche di terra Eduard Bodi le ha fin da piccolo, quando aiutava mamma e papà, orticultori a Cavallino Treporti. Romantico, esteta, artigiano. Oggi a Venezia è capo squadra dei giardinieri ai Giardini Reali di San Marco e all’Orto del Redentore. Alle spalle, anni di apprendistato spesi nel verde più prestigioso: The Holme al Regent’s Park di Londra e San Lazzaro degli Armeni, «l’isola nell’isola della laguna veneziana», sono solo due capitoli dal passato di Edoardo, classe 1974.
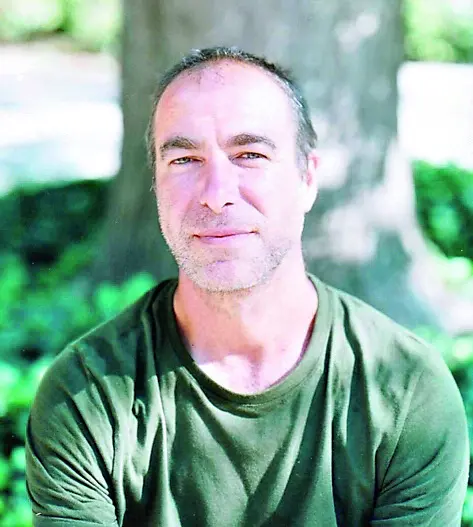
Come descriverebbe il suo mestiere in due parole?
«Citando Massimo De Vico Fallani: “Il bravo giardiniere coltiva il terreno”. La cura della fertilità è al centro».
Dove nasce la sua passione per il giardinaggio?
«Dalle mie radici, a Ca’ Ballarin, e dagli incontri più inattesi. Il nonno e i miei genitori mi hanno trasmesso un forte legame alla terra. Mia madre è stata la mia prima maestra, anche se da giovane rifuggivo il mondo contadino. Lo percepivo limitato e desideravo diventare insegnante di lettere».
E poi cosa accadde?
«Dopo la scuola tecnica mi sono iscritto all’università a Venezia. Cercavo un lavoretto per pagarmi gli studi che i miei non vedevano di buon occhio. Sono arrivato all’azienda Munaretto del Lido di Venezia e lì ho conosciuto una persona straordinaria, Franco Munaretto».
È stato il suo mecenate?
«Direi una guida. Ero fattorino, con l’accordo che studiare non avrebbe interferito su un mestiere che necessita assoluta dedizione. Al suo fianco ho raffinato il mio sguardo e capito cosa significhi essere artigiano».
Si spieghi.
«L’attenzione al particolare, la capacità di mescolare i colori... Fiori e composizione richiedono un occhio attentissimo, conoscenze botaniche e di conservazione. Nel vivaio degli Alberoni, l’azienda curava le piante da interno per gli hotel della Ciga (allora in città erano il Danieli, il Gritti, l’Excelsior, il Des Bains). E così dai fiori mi sono riavvicinato alle piante, al giardinaggio, cosa diversa dal giardino».
Qual è il distinguo?
«Il primo sono le tecniche di coltivazione, il secondo è un concetto. Soprattutto per noi italiani, il giardino non è fatto di sole piante ma anche di persone, animali e architetture. In ogni caso, sintesi perfetta di una bella follia umana».
In che termini?
«È un luogo, e non uno spazio, totalmente slegato dall’utile. Eppure il Tasso e l’Ariosto, Leopardi, Manzoni e altri illustri lo hanno eletto a metafora di qualcosa di grande. Qualcuno lo ha definito “arte totale”: teatro, scultura, letteratura. Per dire quali possibilità infinite ha il giardino di entrare nell’immaginario umano».
Vale ovunque nel mondo?
«Gli europei lo legano alla contemplazione, al passeggiare, gli orientali addirittura alla meditazione, alla filosofia».
E tutto questo emerge dal paesaggio?
«Lo si coglie solo confrontandosi con ambienti diversi».
Quali sono stati i più stimolanti per lei?
«La Scuola Agraria del Parco di Monza, dove ho capito di voler diventare capo giardiniere in un giardino storico. Poi l’Inghilterra, a The Holme, un’ottocentesca dimora nel cuore di Regent’s Park a Londra di un ricco e facoltoso orientale. Pretendeva l’anonimato e arrivava preannunciato il giorno prima. Alla progettazione del giardino pare avesse collaborato Gertrude Jekyll: donna mito del giardinaggio e paesaggismo europeo. Tornato a Venezia ho poi incontrato la mia prima vera mecenate, Jacqueline Massola».
Con quale esito?
«Mi ha affidato il suo giardino – per me un laboratorio – a palazzo Erizzo a San Martino. Poi per tre anni sono stato giardiniere unico nell’isola di San Lazzaro degli Armeni. L’isola nell’isola…».
E oggi, ha tagliato il suo traguardo?
Posso dire di sì. Grazie ad Adele Re Rebaudengo, presidente di Venice Gardens Foundation. Lei ha avuto un sogno più grande del mio: restaurare i Giardini Reali in piazza San Marco, e l’Orto del Redentore alla Giudecca. Entrambi storici, ridiesegnati dall’architetto Paolo Pejrone, e di cui sono giardiniere capo squadra».
Due rarità in un centro storico…
«Ricordo che nel Seicento Venezia era famosa per le proprie accademie in giardino, e l’Orto Botanico di Padova ha rappresentato la prima riserva di conoscenza botanica per i veneziani, unita alla stamperia. Ciò ha portato i nobili ad appassionarsi e collezionare piante esotiche. Un’attitudine per il giardinaggio che oggi si è persa nella cultura media diffusa, sacrificando i luoghi».
Cosa intende dire?
«Che un giardino andrebbe apprezzato di più anche se guardato solo da fuori perché non di proprietà, o di difficile accesso. Il fatto stesso che esista, diceva Rosario Assunto, è un bene comune. Certo può esserci il “contro” del vicinato, ma ricordo a proposito l’uso della pergola tra gli elementi del giardino storico veneziano. Un angolo intimo, di piacere. Casanova docet…».
I suoi tre must da visitare?
«In Inghilterra il Great Dixter e il giardino del castello di Sussinghurst creato da Vita Sackville West. Nel Triveneto, il giardino di Villa Barbarigo Dona Delle Rose di Valsanzibio, una perla dell’umanità».
Riproduzione riservata © La Nuova Venezia



